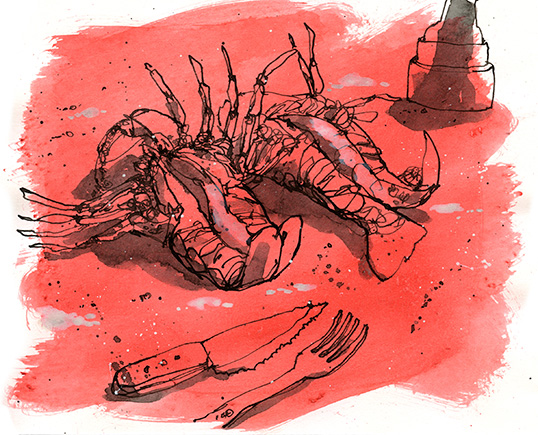Quel giorno, tra i salvati, c’erano delle donne incinte. Quante madri hanno perso i loro figli durante la traversata? Quante non ce l’hanno fatta? Di loro e delle loro croci non sappiamo niente, e non sappiamo se abbiamo colpe, perché le abbiamo e non le abbiamo.
La karavida ha una corazza ancestrale, con pungoli simmetrici, se la spacchi in due è come le barchette o i gusci di noce, due chiglie i cui perimetri a minuscoli zigzag si possono ricomporre precisamente. Con la strumentazione chirurgica ne estraiamo la polpa, entriamo tra i bordi e la carne, che cerchiamo di staccare mantenendo almeno il pezzo principale intatto. Spezziamo le chele e succhiamo. Gli occhi della karavida uscita dall’acqua bollente sono verde scuro, diversamente dalla karavida viva in mare, e sono duri come sassolini. La karavida viva, a differenza dell’aragosta, è circa grigia. All’aragosta cotta vengono spezzate le antenne, che sono molto più lunghe di quelle della karavida: a volte ne rimane su una, che arriva in tavola ancora attaccata per un codice estetico vecchio. Nelle cene con la karavida e nelle cene con l’aragosta si parla dei fatti della giornata, in ordine sparso e impreciso, piccolo, minuto, privato, borghese, precario, pubblico, politico, economico, mondiale, universale, novecentesco, letto su «la Repubblica», il «Corriere della Sera», «Le Scienze», «Internazionale», Internet (sulla bacheca di), il «New Yorker», WhatsApp.
Quella sera con la karavida qualcuno parlava del profugo economico e del profugo politico, qualcuno attaccato al wi-fi leggeva ad alta voce i commenti e i tweet disumani, le risposte a Salvini e Saviano, e poi si parlava delle ONG e della missione Triton, e che così non si può fare. Si stava spesso in silenzio, usando frasi che sono come connettori: perché è tutto ingestibile, non codificabile, troppe informazioni da processare, vere e non vere, troppa stanchezza del giorno, dell’anno, e dunque passami patatine, passami tzatziki, passami olio, limone, sale. In fondo dello tzatziki e dell’aglio sappiamo parlare. Di tutto il resto non sappiamo niente. Non vogliamo.
La karavida, detta anche cicala del mare, ha una corazza durissima eppure sottile. È andata così: un anno prima eravamo soli, gli altri erano in paese, li guardavamo da lontano, dall’alto, tra le case bianche rimpicciolite. Abbiamo camminato tra gli ulivi e indicato la barca che rientrava nel porto. Ci siamo fermati alla chiesa ortodossa, siamo entrati e abbiamo acceso una candela e l’incenso. Siamo usciti, c’era vento, ci siamo seduti per un po’, poi abbiamo deciso di andare fino al faro. Abbiamo superato gli orti e seguito un sentiero tra l’erba secca, senza parlare, compiendo un percorso curvo e in salita, e sapevamo e non sapevamo cosa volevamo fare. Siamo arrivati sull’altipiano che sembrava un deserto secco e giallo e siamo stati in silenzio con le mosche e le cavallette tra i piedi. Allo strapiombo ci siamo detti: come sarebbe buttarsi giù?, e ci siamo avvicinati più al bordo. Siamo tornati nel terreno sicuro e siamo scesi col culo per terra su un sentiero ripido e poco battuto, ripetendoci e però buttarsi giù dalla scogliera?, e immaginando come sarebbe il corpo che cade di peso in volo, come sarebbe lo sbattere scomposto e violento sull’acqua. Poi siamo arrivati alla spiaggia di sassi, e il sole era già quasi sceso. Forse non eravamo alla spiaggia, forse è successo dopo, al rientro, quando il vento sbatteva le persiane e ci siamo chiesti come sarebbe se. Forse è davvero successo: ci siamo avvicinati, abbiamo fatto scivolare le mani, ripetendo un gesto sempre uguale, iniziando a fare quelle cose che tutti sappiamo.
Eravamo infatti circondati: sapevamo dell’amica Anna e della gravidanza di Francesca e dei tentativi di Federica. Sapevamo dai dépliant che si può criogenizzare per quando arriverà il nostro tempo. Sapevamo dei consigli delle amiche: devi buttarti, ora o mai più. Ci hanno spiegato bene il motivo nel #fertilityday: la bellezza non ha età, la fertilità sì. Sapevamo delle beta-hcg e del test di gravidanza precoce. Sapevamo però di Gianna Nannini. Sapevamo dei contratti e non contratti di lavoro, degli uno più uno, del sei più sei, e sapevamo tuttavia del boom demografico del dopoguerra. Sapevamo che in ogni caso, ricorda, sei donna comunque. Sapevamo anche dei figli di consolazione. Allo stesso modo ci hanno spiegato i seggiolini automatizzati che cullano i neonati, e ora sappiamo certamente della gravidanza di Clio, e tra poco potremo seguire su Instagram quella di Chiara.
Da bambina non sai come funziona: per prima cosa si sfalda l’epitelio ghiandolare, la mucosa (e hai molto peccato? e come hai peccato, cosa hai toccato?). Scende qualche goccia, poi, anche di notte al buio, in orizzontale, come un lutto esonda. Dentro ripulisce, tutto si crea da capo mentre fuori sporca. Ti alzi ti accucci e ti sciacqui (o Gesù d’amore acceso), con il concavo della mano raccogli acqua e la appoggi al concavo e l’acqua si fa rosata o rossa. Sciacqui ancora e sembra finito, ma è per poco. Le prime volte è un mistero (propongo col Tuo santo aiuto di non offenderti mai più). Poi impari come si fa, aggiusti per non sporcare, ti fai una tecnica che userai per gli anni a venire come un rituale. Impari la durata di quei giorni, delle tue cose (libera di muoverti, la tua idea di libertà, nessuno assorbe e ti protegge così tanto).
Se hai dodici anni, da lì in poi ti attendono forse cinquecento, settecento cose. Fatta eccezione per il tramonto alla spiaggia di sassi, quando il sole è già quasi sceso (dieci Ave Maria e un Padre Nostro): allora quattrocento milioni di elementi risalgono dentro con il loro movimento ondulatorio, con l’oscillare della coda spinta nel fluido; allora uno sale, uno entra, uno crea (sappiamo infatti che per fare l’albero ci vuole il seme). Per prima cosa gli elementi contengono il DNA, den den. Si muovono nel tubo a ritmo del Duo des fleurs di Léo Delibes, al minuto 00:54 gli elementi migliori salgono nel collo uterino, si incastrano nelle caverne della cervice, rallentano, al minuto 1:15 sono nelle tube, i rimasti si spandono, si fermano, degenerano, uno al minuto 1:36 trova l’ovulo (follicoli, estradiolo, corpo luteo, progesterone), si artiglia e si fonde. Poi l’ovulo scende nell’utero, si appoggia e si impianta. Questo dentro, quando fuori non c’è ancora un segno. Possiamo tutto questo chiamarlo opera del Signore? Intanto lodiamo il frutto del lavoro dell’uovo, la meccanica dei movimenti uterini, la precisione della replica cellulare, la potenza della forma elicoidale, e lodata sia la biologia molecolare («è come un grano di senape, il più piccolo dei semi, ma quando cade sul terreno coltivato produce una grande pianta e diventa un riparo per gli uccelli del cielo»).
Dicevamo che la karavida, detta anche Scyllarides latus, ha una corazza molto forte. Si riproduce in primavera, proteggendo le uova sotto l’addome. Ci dicevano di aspettare i tre mesi, ma quella cosa ancora invisibile era già come viva. Scoprimmo invece che non sapevamo niente: e mentre fuori facevamo festa, dentro c’era una battaglia primordiale.
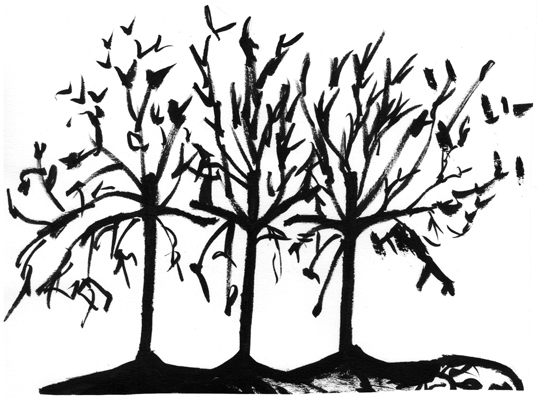
Artwork by Emmanuela Carbé
Scoprimmo che il nostro lutto si chiama solo incidente di percorso. Sappiamo ora che succede spesso. Google ti affida allora ai forum delle non madri che cercano di diventare madri: alcune non ce l’hanno fatta più volte, altre hanno fatto solo pochi tentativi. Prima di arrivarci provammo le strade più scientifiche di Google Scholar e Google Books, poi Google Immagini, infine loro. Sapevamo già da anni dei gruppi Giovanissime Mammine e Giovanissime Pancine, perché molti amici davano in pasto alle pubbliche risate i loro commenti, e sapevamo delle foto di minuscoli bambini in affidamento temporaneo a Facebook Inc. Questo era un altro pianeta ancora, indecifrabile come tutti gli altri, e iniziammo a registrarne i movimenti. In quei luoghi oscuri e pieni di cuori, gli pseudonimi sanno di potersi confessare. Lì possono contare i giorni insieme e comunicare nel codice cifrato della tribù, comprensibile solo agli iniziati: canadesi, PO, PM, le malefiche, i fantasintomi, le rosse, stimolazione, fare i compitini, non le aspetto per il 20 gennaio, chi non le aspetta per settembre?, linea chiarissima posso sperare? Smontano i testi, li analizzano e fotografano, chiedono: ho speranze? I thread di discussione sono lunghi, ma quasi tutti vengono troncati all’improvviso. Quando il thread è abbandonato significa che è andata male. Ogni thread ha una sua croce e non possiamo giudicare, perché di loro non sappiamo niente.
Non sappiamo nulla in nessun ordine di grandezza: cosa sappiamo delle madri violentate, e cosa di quelle che vivono in terapia neonatale; cosa sappiamo di quelle che persero i figli negli attentati, delle madri dell’11 settembre, le madri dei jumpers (ma ci furono anche le jumpers – la tumbling woman – e noi le sappiamo ricordare?). Non sappiamo di Bozaina Mohamed Mustafa Sheraqi, madre di Atta (mio figlio è vivo, complotto USA, Guantánamo) e della madre di Youssef Zaghba (passami tzatziki, passami sale). Non sappiamo delle madri dei due ladroni sulla croce, Tito e Dimaco o Dumaco Dismas Disma, Demas e Gesta ovvero Zoatha e Camma o Chammata, o Joatha e Maggratas. Di Maria Vergine madre di Dio dovremmo sapere tutto e sappiamo ancora meno, non sappiamo della sua assenza di mestruazione, della sua felicità o terrore, il suo essere speciale, il dolore, l’accelerazione del sangue; sappiamo la mano a forma di protezione e lo sappiamo per il Piero Della Francesca 1455–1465 circa: Maria qui non sorregge alcun libro, si appoggia con l’altra mano sul fianco, è stanca, ha l’abito in parte sbottonato e il viso è serio e teso. Forse sente scalciare (oppure lui non scalciava?). Forse ha sofferto anche lei durante il parto. Sia lodata la madre che piange il figlio, la madre del terrorista e la madre del kamikaze, la madre che non ha potuto o voluto essere madre. Siano lodate tutte loro, perché di loro non sappiamo niente.
Sia lodata anche la nostra Maria, vedova, che ha perso un figlio sette anni fa, morto sull’isola vicina dove avevano le capre e le viti: si è tagliato un polso con la motosega ed era solo, il cellulare non aveva campo; ha tentato allora di tornare a casa e un peschereccio l’ha trovato al largo con una maglietta stretta al polso, steso nella sua barca, una chiglia piena di sangue con il motore spento. Le donne al molo si strappavano i capelli urlando. Maria non ha più età ed è come assente: sorride, cuoce il pane, sta seduta davanti alla porta di casa. La domenica va in chiesa. Ha due trecce grigie nascoste sotto il copricapo, che è nero. Maria affitta le stanze per l’estate, non sa l’inglese. Sono entrata nella sua cucina per darle i soldi del mese. Mi parla in greco, io annuisco e rispondo in italiano, proviamo a capirci a gesti. Mi ha offerto l’uva, le ho detto questa sera pesce, il figlio di Kostas ha pescato i kalamares, lei ha detto ai, kalamares. Abbiamo parlato dei fatti della settimana, o così mi pare, del matrimonio che c’è stato in paese, il terremoto che non si è sentito, i migranti arrivati sull’isola vicina e quel pane che mi è piaciuto molto. Le ho mostrato su Google Maps dove si trova l’Egitto e lei si è stupita, mi pareva che dicesse ai, ma la Siria è così vicina? Mi ha chiesto anche quest’anno se ho figli, e io le ho fatto segno di no, e lei mi ha detto ai diskola, ai diskola, e le ho sorriso aprendo le mani, le ho detto sì Maria, e le ho stretto le mani, veramente sola.
La karavida, la cicala dei mari, ha una corazza ancestrale. La osservo nella sua simmetrica perfezione e rimango stupita. Mi sono data il compito di staccare più polpa possibile e trasbordarla da un piatto all’altro. Passare nel frattempo patatine, tzatziki, olio, limone, sale. Finita la cena prendo le due parti della corazza e provo a raschiare gli ultimi pezzi ancora attaccati; mi accanisco con il coltello, la voglio completamente svuotata, pulita. Cerco di ricomporla in un unico pezzo, la tengo in verticale e tocco lungo le schegge protettive che spuntano dalle due zanne conficcate davanti. Gioco con le giunture delle chele, le alzo e le abbasso come se fosse un riscaldamento muscolare. Ne spezzo una per osservare l’interno delle giunture, che sono palline, e mi faccio male. Premo piano con le dita, tasto gli occhi, ne faccio saltare uno e provo a schiacciarlo, ma è duro, inizio quindi a rotolarlo con l’indice. A Ellis Island ci sono stata anche io, dico agli altri nascondendo l’occhio sotto il tovagliolo. Ordiniamo del raki. Vado in bagno a lavarmi le mani e mi vergogno.
L’Anek Lines dell’orario notturno, con le sue piccole luci, si sta avvicinando al porto. Ogni volta ci alziamo dai tavoli per guardarla meglio. I greci commentano le manovre, quest’anno c’è un capitano nuovo, la settimana prima non è riuscito ad arrivare al molo per il troppo vento. L’Anek Lines è piena di grazia, nonostante le tonnellate addosso, si muove su sé stessa e gira, sfidando le onde senza nemmeno barcollare arriva e si appoggia con due cime ai pochi metri del ciglio di attracco. Allora la nave si salda a riva e la passerella finisce di scendere scricchiolando, piccole ombre di uomini e auto escono in fila indiana. Certo succede: facendo scivolare una mano tra le sue, ripetendo un gesto affettuoso e sempre uguale, senza sapere il motivo. Avvicinandosi alla sua fronte, dimenticando ancora una volta che di quella battaglia primitiva non sappiamo niente.