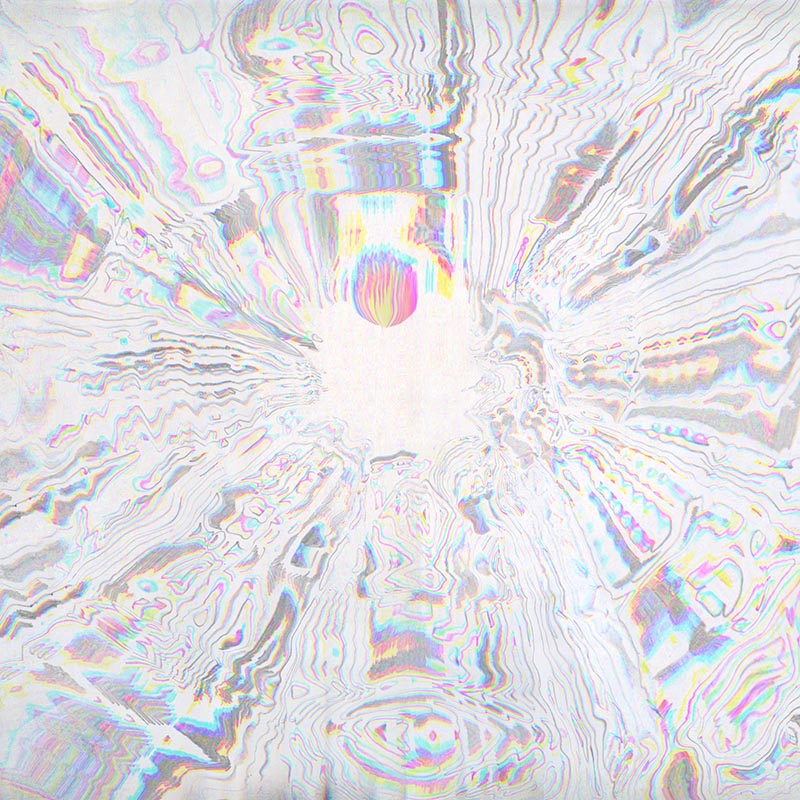Non c’è mai stata, né mai ci sarà, vita umana senza apparizioni.
Ecco il bambino.
Ecco l’apparizione.
Respiro
La sera del 30 giugno 2017, a Charkiv, Ucraina, Dasha Medveveva, ventiquattro anni, sta guidando la sua BMW. La sua amica, Sofia Magerko, sedici anni, con lo smartphone filma il momento. Siamo in diretta su Instagram.
Le due amiche bevono alcol, urlano, scherzano. Una grida “hi boys” alla camera. Dasha fa il segno della vittoria, indice e medio, con entrambe le mani. Solleva le braccia in aria, accennando una danza. Viene il dubbio che la macchina non sia in movimento, ma poi Dasha tiene il volante, per qualche secondo, con la mano sinistra, guarda la strada. Ritorna con lo sguardo in camera, Sofia sposta l’obiettivo su di lei. Segno della vittoria. Un altro sorso. Urlano. Rumore di “tremendo impatto”. Buio. Silenzio.
Guardo la scena giorni dopo sul sito di un quotidiano italiano che annuncia: “Ucraina, morte in diretta su Instagram: due ragazze si schiantano in auto”.
La guardo mille volte. Prima esploro, tra un pause e un play, l’istante in cui tutto cambia. Il passaggio tra la vita e la morte. Quale l’ultimo respiro?
Poi mi soffermo sulle ragazze. Cerco di studiare ogni singolo dettaglio del viso di Dasha, ma è buio, fuori è notte, e lei si muove continuamente.
Ne sono certo.
Nessun dubbio: conosco quella ragazza.
Luce
Che cos’è un’apparizione?
Tutto appare: viene alla luce.
Il nostro stare al mondo è un flusso continuo di eventi improvvisi e inaspettati. Tutto ciò che ci accade, giorno dopo giorno, minuto dopo minuto, è un evento improvviso e inatteso: la coda in automobile in una città di provincia in estate (un piccolo tamponamento imprevisto davanti a noi e via, dieci minuti inaspettati), la caldaia che smette di funzionare, la presenza di un qualunque cliente nel bar dove prendiamo il caffè (se non è improvvisa e inattesa la presenza di un altro cliente, lo è, invece, la presenza di quel determinato cliente: perché proprio lui, con la pancia da alcolista? E lui, con il volto anonimo, dimenticabile? Perché proprio lei, con le unghie glitterate?).
Per trovarci di fronte a un’apparizione, non basta però che quell’evento sia improvviso e inaspettato.
Un’apparizione può avere molteplici forme. Generare straniamento, per esempio (la donna dalle unghie glitterate non è solo presenza, ma è presenza che strania: vi guarda negli occhi, feroce, e non parla: cosa starà pensando? È davvero feroce? La ferocia è nei vostri occhi e non nei suoi?). Un’apparizione può plasmare l’asse lineare degli eventi per come lo avevamo concepito.“ (per eludere il tamponamento, passeremo per una via secondaria: lí, su quelle strade di campagna, vedremo il cadavere di un cane probabilmente investito: una goccia di malinconia ci pervaderà), oppure modificare il nostro stato d’animo (il difetto della caldaia ci farà ritardare a un appuntamento a cui tenevamo: usciremo lo stesso senza doccia, e allora ci sentiremo in imbarazzo, come sporchi, fangosi? Oppure attenderemo e faremo tardi e genereremo attesa presso chi ci aspetta e dunque presso di noi?). Un’apparizione, senza dubbio, è generata da una novità o da un ritorno. Venire alla luce, forse da un’ombra. Un’apparizione può plasmare non solo il tempo ma anche lo spazio. Distorcere l’immaginazione.
In ogni caso, l’apparizione, per essere tale, genera un mutamento.
Affinché un’apparizione viva in tutta la sua forza, sono necessarie alcune condizioni preliminari. È necessaria, innanzitutto, la possibilità di una consapevolezza: essere consapevoli di come un oggetto o un pensiero vengano da noi percepiti; essere consapevoli di quale sia la nostra reazione emotiva a quell’oggetto o a quel pensiero (pensare: ora, esattamente ora, sto pensando questo pensiero), essere consapevoli di noi stessi in relazione al contesto. Tentare, in rari casi, di essere noi stessi l’atto di osservare. Essere comunque il piú possibile presenti. Ipotizziamo, caso inaudito, un essere umano senza consapevolezza: si avrà un essere umano senza apparizioni.
Altra condizione affinché la percezione viva è la disponibilità alla contemplazione. “Contemplare”, “contemplari”: attrarre nel proprio orizzonte; osservare (il volo degli uccelli) entro uno spazio circoscritto detto templum.
Non c’è vita umana senza apparizioni. Per essere però consapevoli di piú apparizioni possibili non si può che rovesciare tutto: per contemplare non basta stare fermi, immobili. È necessario costruire uno spazio interiore e rimodellarlo giorno dopo giorno. Andare incontro allo shock dell’ignoto. Contemplare non è stare fermi e attendere il mondo: è andare incontro al mondo, espandere il proprio templum e, parallelamente, aumentare la consapevolezza. La contemplazione è un importante architrave dell’apparizione: osserva il mondo, dunque osserva te stesso, dunque vivi.”
Un’apparizione può mutare, talvolta solo impercettibilmente, il flusso degli eventi.
A seguito di un’apparizione, le sensazioni che proviamo sul nostro corpo generano un cambio di direzione, una virata o un’accelerazione. Senza sensazione non c’è apparizione. Senza sensazione non c’è essere umano. Che cos’è quella malinconia per il cadavere del cane? Un peso sullo stomaco, un brivido dietro la schiena, un sussulto del respiro. Che cos’è quella sensazione di disagio per la rottura della caldaia? Un prurito, una sensazione di calore, una sensazione di pesantezza.
Un’apparizione porta mutamento. Le apparizioni si insinuano ovunque: come microbi si nascondono nella flanella dei cuscini. Dobbiamo ringraziarle. È grazie a loro che ci sentiamo vivi.
Dasha, hi boys, era un’apparizione.
Incantamento
La nostra mente è attraversata ogni giorno da un numero di pensieri che oscilla fra i cinquantamila e gli ottantamila. Quando, per un istante, questo fiume di pensieri si ferma, è piú probabile che arrivi l’apparizione. Piú è fitto il chiacchiericcio della nostra mente, piú sarà difficile far vivere l’apparizione, se è vero che per vivere l’apparizione, sentirla, c’è bisogno di consapevolezza. Piú siamo disposti, aperti all’apparizione, piú sarà possibile vivere la condizione necessaria per un’apparizione: l’esperienza.
Non sempre le esperienze coincidono con le apparizioni. Ogni esperienza genera un mutamento? Sí. Ogni esperienza genera un mutamento consapevole? No. Siamo fermi sul divano e ci sembra di non fare assolutamente nulla. Sta succedendo qualcosa? Sí. Le molecole nel nostro corpo non sono immobili. A farci caso, un lontano prurito tocca il mignolo del piede. Se non ne siamo consapevoli, tuttavia—e se cioè non siamo attenti a quanto sta accadendo—la possibilità che quest’esperienza di mutamento non sia consapevole è piuttosto alta. Le apparizioni dunque, in un caso come questo, sono apparentemente lontane.
In questo caso, sí: quest’esperienza era un’apparizione. L’asse spazio-temporale della propria interiorità si sposta, le percezioni si fanno piú intense, la consapevolezza “aumenta, la mente è piú concentrata, ed è ridotta la sua germinazione tipica di fatti inutili, parole inutili, movimenti che saranno dimenticati in pochi secondi.
Non sempre l’apparizione si presenta come tale. Talvolta è piú sottile, emette qualche vibrazione e stop: qualcosa, dentro di te, ti dice che forse, per qualche ragione, questo momento ritornerà, ciò che hai visto riapparirà nella tua mente: è come un grande testo letterario, questa vita. Accade e basta. È contemplazione piú che narrazione.
Questa volta sí: l’apparizione si configurò subito come tale.
Invitato in una piccola galleria d’arte, dove si sarebbe tenuta una performance di un’artista a me ignota, la mente aveva già iniziato a volare. Domani, domani, dopodomani. Guardare la partita, morire, cambiare città. La mente è il cavallo e noi siamo il fantino: ci porta 1lontano.
Erano poche ore che avevo visto la “morte in diretta”: un’apparizione l’avevo già avuta (si possiedono le apparizioni? O si subiscono? Si inabissano dentro di noi e noi vi nuotiamo dentro? O troneggiano come dèi greci nella nostra mente? Vivono anche quando dormiamo? Certo che sí! Vivono anche quando moriamo? Certo che no!).
Ma ne arrivò un’altra, di natura molto diversa.
Fuori dalla galleria d’arte Il Colorificio, saluto. Poi entro. L’artista, Tamara MacArthur, inglese nata a Berlino e che vive a Glasgow, è al centro della scena.
Il suo viso spunta da un corpo femminile fatto di cartapesta, che a sua volta sorregge un corpo maschile di cartapesta. Attorno: una vera cappella di cartapesta, a struttura romanica, da lei costruita in un mese di vita all’interno dello spazio espositivo. Il cielo è stellato all’inverosimile, da cartone animato.
Le colonne della cappella sono autoritratti dell’artista, esplosi, fragilissimi (è davvero ridicolo tentare di descrivere una performance artistica: le parole sono strumenti cosí umani…).
Tamara canta.
Entro.
In quel momento sono l’unico visitatore di fronte a lei. Canta e mi guarda negli occhi. La voce è rotta. Ti guarda negli occhi e non si stacca mai piú. Vuoi uscire da quello sguardo e al tempo stesso vuoi che si prolunghi all’infinito. Non c’è erotismo, non c’è mestizia, non c’è disperazione, non c’è compli“complicità: c’è tutto questo e altro. Tamara canta: “If I had words to make a day for you, I sing you a morning golden and new”. Siamo dentro l’incantamento. La canzone, dello scozzese Scott Fitzgerald, è quella che, nel film, il contadino canta a Babe il maialino, nella speranza di curarlo. Il contadino canta dolcemente, ma non sembra credere davvero alla magia. Poi accade qualcosa: la consapevolezza che qualcosa può cambiare.
Ero di fronte a un’esperienza artistica: le esperienze artistiche sono sempre apparizioni.
Provi a fuggire, strappi e vai via, vai nell’altra piccola cappella di cartapesta. Ma devi tornare. La nenia continua. La canzone è sempre la stessa, infinita, per tre ore e mezza. Gli occhi sono sempre gli stessi. Ogni singolo istante è importante quanto il precedente. Non c’è pubblico. Ogni visitatore è l’unico e solo possibile per lei, per lunghissimi minuti. Non c’è madre e non c’è parto. Non c’è origine né addio.
Non andare via. Non abbandonarmi. Il momento dell’abbandono è sospeso. Sembra che non finirà mai. Poi arrivano altri visitatori. Sei tu a sentirti abbandonato. Tamara fissa le pupille di un altro. Canta la canzone della cura, se avessi le parole, il rito magico. Tu sei invisibile. Provi a chiudere gli occhi ma non serve a nulla. Sul tuo corpo, senti le molecole in movimento. Brividi, calori. Sensazioni. Esplodono, per contatto umano.
Ciò che è apparso è ancora lí e tu non sei niente: neanche un piccolo fantasma.
Mente e coscienza
Come è evidente, affinché le apparizioni accadano c’è bisogno di un sistema integrato.
Per le neuroscienze cognitive contemporanee, secondo Stanislas Dehaene, bisogna distinguere tre concetti:
- Vigilanza, chiamata anche veglia: è ciò che varia quando dormiamo o siamo svegli. È condizione necessaria, ma non sufficiente, dell’accesso e dell’elaborazione coscienti.
- Attenzione selettiva: è il concentrarsi delle risorse mentali su un sottoinsieme di informazioni. L’attenzione sceglie alcune informazioni, le stacca dallo sfondo e approfondisce la loro elaborazione. L’attenzione selettiva è caratteristicamente un processo inconsapevole che dà accesso alla coscienza.
- Accesso cosciente: è l’ingresso di una parte delle informazioni trattate in un secondo stadio post-percettivo di elaborazione cognitiva che le rende durevoli, disponibili per molti processi cognitivi ulteriori e riferibili ad altri. Sono cosciente di aver cambiato lavoro. Posso riferirlo a un mio amico. Questo mi farà pensare che dovrò fare un tragitto diverso in scooter, al mattino. Queste informazioni sono sottoposte, ora, a elaborazione consapevole: incanalate, in maniera seriale, attraverso una serie di stadi controllati di elaborazione.
In laboratorio, secondo Dehaene, è possibile indagare decine di maniere con cui uno stimolo può attraversare il confine fra il non percepito e il percepito, fra l’attenzione selettiva e l’accesso cosciente, fra l’invisibile e il visibile, permettendo ai neuroscienziati di comprendere cosa cambia nel cervello durante questi passaggi.
(Come la letteratura affronta quel confine? Può la letteratura non occuparsi di quel confine? Può mai ridursi a semplificare il mondo? Questo si vede e questo non si vede: e questo è tutto!)
Negli Schizzi pirroniani di Sesto Empirico, si segnala quanto accade ad Aristotele: da lontano vede una torre che gli sembra rotonda. Ne è certo. Avvicinandosi, riconosce che invece ha forma rettangolare. Conclude che la conformazione apparente della torre dipende da dove l’osservatore si trova e che solo spostandosi può scoprire la forma autentica.
Se però la torre ha forma rettangolare—almeno cosí sembra… –, non è altrettanto facile dire che la performance di Tamara MacArthur fosse esattamente come qui è stata descritta. Non tanto nella sua attuazione, quanto piuttosto nella reazione. Dove c’è un corpo e dunque dove c’è una mente c’è un particolare tipo di consapevolezza legato a un particolare istante e a un particolare contesto: “qual era la predisposizione, in quel preciso momento, di un altro visitatore? Aveva fame ed era meno concentrato sulla performance? La sua mente lo portava al kebabbaro Mickey Mouse accanto alla galleria—che peraltro pubblicizzava, con un cartello scritto a mano, uno sconto di cinquanta centesimi a kebab per i visitatori della mostra? Quale il suo bagaglio di vita, quale il suo DNA? Quell’artista le ricordava sua cugina? Sua nonna? Il suo viaggio in Argentina?
La mente è spesso lí, da qualche altra parte, in un’altra direzione.
Nella geografia intricata di ciò che chiamiamo “io”, non si può non delineare quel luogo spesso ignoto che si chiama: coscienza.
Nel 1804, il medico e filosofo Ignaz Paul Vital Troxler scoprí un particolare fenomeno della percezione visiva. L’illusione ottica che divenne il motore dello studio fu detta “effetto Troxler”.
Provate a fissare la croce centrale, e a essere consapevoli di quanto accadrà ai cerchi circostanti. Come vedrete, svaniranno, spariranno: poi ricompariranno in maniera casuale.
La rappresentazione visiva fissa oggettiva compare e scompare dalla nostra rappresentazione soggettiva a ritmi irregolari, imprevedibili: per apparizioni.
L’effetto è dovuto a un meccanismo di adattamento dei neuroni preposti alla vista, in particolare delle cellule oculari sensibili alla luce nella retina: le cellule si abituano all’immagine e dopo un po’ non percepiscono piú lo stimolo visivo circostante.
Cosa ci dice, tra le altre cose, l’effetto Troxler? Che le illusioni ottiche—che saranno poi utilizzate per studiare la coscienza a partire dalle ricerche di Francis Crick e Christof Koch—non richiedono un elaborato livello di coscienza.
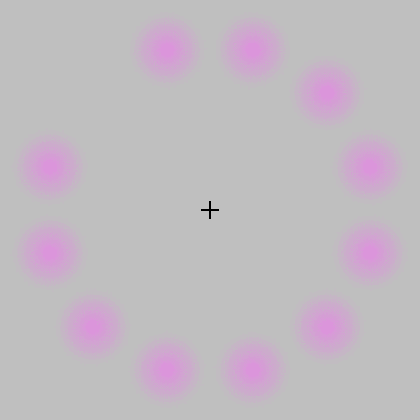
Altro aspetto importante è che le illusioni sono profondamente soggettive: solo il singolo individuo può dire quando e dove i cerchi scompaiono nella propria mente. Al tempo stesso, i risultati sono totalmente riproducibili: qualsiasi persona osservi la figura, riferirà di aver vissuto lo stesso tipo di esperienza.
Apparizioni, dunque, molte—i cerchi compaiono, scompaiono “a casaccio”. Certezza, però, che questo accada. Da questo punto di vista, la letteratura—e cosí nel caso di If you believed in me, la performance di Tamara MacArthur—vive di una differenza: solo il singolo individuo può dire quando, dove, quanto e come l’esperienza artistica abbia intaccato la sua consapevolezza—dimenticare, per cosí dire, il passato e il futuro –, e quando e quanto no. Al tempo stesso, i “risultati”—necessarie le virgolette: le esperienze artistiche non vanno in classifica né sul ring—sono totalmente diversi da individuo a individuo.
Se molte persone al mondo ritengono che la Nike di Samotracia, l’Odissea e il Don Giovanni di Mozart siano dei capolavori assoluti, è impossibile dire che queste opere abbiano generato la stessa identica sensazione in ogni singolo istante a due persone diverse.
Apparizioni a Manhattan
Qualche settimana prima, a New York.
Colazione, a Soho, da Dominique Ansel. Un’ora di coda per mangiare il cronut, un’invenzione culinaria che fonde il concetto di croissant e quello di donut. Pasticceria come feticcio. Pasticceria come monumento. Entrare, scattare, instagrammare e via, verso un’altra Torre di Pisa, un’altra Sagrada Familia.
Mattinata al Guggenheim, dove c’è la temporanea di Agnes Martin. A guardarle distrattamente, quelle tele potrebbero sembrare il massimo dell’astrazione o dell’arte concettuale. Reticoli di linee orizzontali e verticali ripetuti sulla tela in modo uniforme. Le trame però sono sfocate: a guardarle a lungo sembra che possano scomparire sotto ai nostri occhi, come i cerchi dell’effetto Troxler. Ogni singolo istante in cui la mano muove la matita—spesso Agnes Martin dipinge su tela con una matita: per una matita, una tela diventa luogo ignoto, bosco inesplorabile—è decisivo. Dietro ogni microscopico segmento di linee c’è un piccolo respiro: ma una linea è un continuum, non ha segmenti, sezioni. Il tempo è la materia stessa dei dipinti di Agnes Martin.
Siamo di fronte a tele di pura contemplazione: intrise di pura apparizione.
Se l’opera è fatta del momento in cui viene eseguita, queste griglie scolastiche, questi quaderni di scuola elementare, sono esperienze artistiche di pura vita e di pura impermanenza: nascondono, dietro il bianco della tela, la presenza della vita, del tempo che scorre: dunque, della morte.
Uscendo, leggo su un pannello: “My life is nothing—there is no incident—it’s as though I never existed” (Agnes Martin).
Dopo un hamburger in un food truck—una piccola apparizione: un cetriolo inaspettato, non richiesto, che guasta la croccantezza del bacon, contamina il sapore della carne surgelata intrisa di olio di colza: sono gli stessi hamburger che, comprati al banco dei surgelati, annunciano sulla loro confezione, in corpo piccolissimo: “Nonostante gli accurati controlli, consigliamo di prestare attenzione alla possibile presenza occasionale di ossicini”: un’altra apparizione, di inquietudine e piccola morte –, si va al cinema nell’Upper East Side.
Proiettano The Adventures of Prince Achmed di Lotte Reiniger, un film considerato da molti il primo lungometraggio d’animazione. Si tratta di un cosiddetto “film di silhouette”. Costituito da 300.000 inquadrature, i personaggi, realizzati in piombo e cartone, furono composti utilizzando da 25 a 50 pezzi separati, tenuti insieme da sottili fili di metallo. Per la facitura del film, ispirato a Le mille e una notte, Reiniger e i suoi collaboratori—tra cui Walter Ruttmann che sarà, pochi anni dopo, al centro di un appassionante caso cinematografico-politico-letterario, tra Mussolini, Pirandello e Soldati, con il film Acciaio—avevano introdotto immagini ed effetti realizzati con altre tecniche d’animazione, ottenuti per esempio con la sabbia, o tramite il cosiddetto “apparato Fischinger”, ideato da Oskar Fischinger: l’attrezzo consisteva in una sorta di affilatrice sincronizzata con una macchina da presa e munita di una lama circolare rotante, la quale, a ogni giro compiuto, tagliava via una sottile fetta da un blocco composto di innumerevoli strati di cera di colori differenti. La macchina da presa filmava “a passo uno” la superficie del blocco di cera dopo ciascun taglio, generando una particolare animazione astratta. Chi sono i personaggi? Le figure—silhouette snodabili ricavate da cartoncino e da lamine in piombo, poi schiacciate da un rullo e messe in scena e mosse, come burattini, su un piano illuminato composto da strati di carta velina—non sono che ombre cinesi. Pressoché nullo è il montaggio. La camera rincorre le ombre, che sembrano autonome, imbizzarrite, dentro un sogno. L’ombra-Achmed incontra streghe e stregoni, li affronta, deve conquistare l’ombra-principessa. Infinite le apparizioni: dove c’è un’apparizione, dove c’è esperienza artistica, c’è ombra.
Alla sera, al Madison Square Garden, per vedere il basket, lo sport piú veloce e piú contemplativo che esista. I New York Knicks ospitano i Milwaukee Bucks in regular season. Perderanno all’ultimo secondo. Il tifo non è assordante: si canta soltanto continuamente, e con tono un po’ flemmatico, “defence, defence”. Durante l’intervallo vado in coda a prendere una birra, ma, quando sto per ordinare, mi accorgo di aver lasciato il documento nella borsa, sul sedile del palazzetto. Quando la donna alla cassa mi chiede il documento, gli dico che non ce l’ho con me, con un sorriso; lei mi nega la possibilità della birra. Le dico che è impossibile che io sia minorenne e che dunque può farmi lo scontrino (d’altronde, I’m Italian…). Lei risponde di no, che le regole sono regole, e mi prega di togliermi di mezzo, quando arriva un’apparizione: una ragazza dietro di me, fisico e viso da modella, dice: “Te la prendo io”. Sorrido, le do i dollari per la mia birra, ma anche per la sua.
Ordina due birre, non ci parliamo, c’è troppo caos. Quando, nell’altra fila, ce le danno in mano, brindiamo. Le chiedo come si chiama. Dasha, mi dice, e vengo “dall’Ucraina. I’m Italian!
Sorride.
Se ne va.
Corpo e coscienza
Che cos’è questa volontà di potenza della mente, questo nostro pensare al corpo, questa ostinazione? Il nostro inno al corpo quotidiano non è che un inno alla morte. Ecco il bambino. Nasce. Il suo corpo. Poi muore. Il suo corpo.
Il corpo di Dasha vivo. Il corpo di Dasha morto.
Il corpo, naturalmente, è sede di apparizioni. Oh, un nuovo neo. Ricordo che qui, all’altezza del bicipite, ne avevo tre, ora sono quattro. Che cosa sarà mai questo rigonfiamento dietro il seno, mentre faccio la doccia? Solo un’apparizione, una piccola apparizione. L’apparizione, come è chiaro, non è soltanto il neo, o il nodulo: bensí la sensazione corporea che questo genera.
Ogni istante è decisivo. Nel basket c’è un momento in cui, dopo un grosso scarto, sembra che una squadra stia per rimontare. Da –20 a –9 in pochi minuti. Si gioca tutto lí. Attacca chi è avanti. La sensazione è che, se gli altri fanno un canestro, la rimonta sarà fermata. L’inerzia sarà bloccata. È tutto lí. L’apparizione nel corpo: il confine tra una piccola e innocua cisti e un cancro è strettissimo. È tutta questione di istanti e di millimetri. Ora è una cisti, continuerò a vivere, ecco l’aperitivo. Ora è un cancro, è finita.
Quante piccole, inutili apparizioni ancora, dentro quella scatola di latta che è il corpo. Su YouTube, milioni di persone osservano video dove brufoli e punti neri vengono schiacciati da una mano sapiente. Doppia apparizione: prima brufolo, poi pus.
Apparizione dello sgomento: molte le visualizzazioni di un video in cui viene tirato, con una siringa, il sangue a un bambino. Il bambino ha paura e urla. Guardiamo.
Che cos’è questo nostro guardare, ridere, addolorarsi dentro e fuori dal corpo? Riposa in pace. I nostri corpi in cenere. Sarò cremato! Voglio essere seppellito lí, proprio vicino a lei.
Dove c’è corpo, in qualche modo, c’è coscienza. Uno dei ruoli principali della coscienza ha a che fare con l’eternità—anche la coscienza ha le sue ossessioni –: creare pensieri duraturi.
Tra i tanti pensieri duraturi, Dasha si stava insinuando con cautela (eppure quell’immagine aveva sempre un’interferenza: era il canto delle libellule di Tamara MacArthur). Era evidente, ne ero certo, che avevo conosciuto quella donna che era morta in diretta. Come dimenticare quell’apparizione? Era evidente, ne ero certo, che era uno scherzo della mia mente—ce ne sono di di donne in Ucraina, ero davvero sicuro si chiamasse Dasha?, e se era davvero cosí, quanto è diffuso quel nome in Ucraina?, e poi quel video è sgranato, con quella donna avevo trascorso al massimo un minuto della mia vita, non c’era alcuna ragione di credere che fosse lei, e soprattutto: cosa cambia? Che importa?
Avevo avuto momenti drammatici nella mia vita? Diversi, mi sembrava, e disperati. Con quante persone che sarebbero poi morte ero già venuto in contatto? Diverse, certamente, come tutti. Esisteva la disperazione? “Solo l’infelicità è degli uomini, la disperazione è di Dio”, ha scritto Gesualdo Bufalino, e aveva torto.
È cosí umana la disperazione, cosí corporea—e non era questo il caso, non era certo disperazione questa, disperarsi per la morte di una persona incrociata, forse, ma davvero forse, una persona che hai solo la vaghissima possibilità di avere incrociato –, ed è cosí dura.
Con la disperazione, la mente è sovraccarica, il corpo è una botte. La disperazione vera è per sempre, come un terremoto. È forse questo il motore della nostra millenaria indagine sul corpo: la disperazione è per sempre, come la pelle.
Fritz Steiniger ha osservato, presso certi ratti femmina, uno speciale modo di ammazzare i compagni di specie. Un ratto si avvicina lentamente, furtivo, a un altro ratto, che sta mangiando. Nel momento giusto: l’azione. Quindi, per la vittima: l’apparizione ultima. Un morso repentino sul lato del collo che centra, con straordinaria precisione, la carotide. Parte una lotta che dura pochissimi secondi.
Il ratto colpito si dissangua all’interno, e sotto la pelle o in cavità del corpo si trovano estesi travasi di sangue.
Cosí noi con noi stessi.
Cosí la nostra mente boicotta noi stessi—conosco quella donna, mi sta dicendo qualcosa, la sua morte è un contagio, morirò, potevamo amarci, ci siamo amati, la birra.
E allora c’è il corpo, il custode, l’eroe, il primo a cadere. Il corpo: implorando il ritorno all’inorganico, non si nega nulla.
In Monika and Pawel, lo scultore Pawel Althamer ritrae se stesso con la moglie, nudi. A ben guardare, da vicino, la scultura è fatta di intestini di animali. Corpo morto che rivive come materia prima in corpo morto e vivo al tempo stesso, in rappresentazione: forse sono vivo, scolpisco noi stessi (ci uccido!) e compongo noi stessi con carne viva e morta.
Rovescia se stessa la scrittrice Clarice Lispector: G.H., la protagonista di La passione secondo G.H., sfrutta le ferie della governante per curiosare nel suo armadio. Trova una blatta, trova il corpo immondo. La guarda. G.H. sta per “genere umano”. Un ammonimento. Una speranza. Un’illusione. Una minaccia.
Spaziosità
Dietro le esperienze artistiche, c’è sempre una spinta invisibile. Di qualsiasi forma siano, le esperienze artistiche dispongono di un testo: non c’è testo senza ciò che c’è dietro, davanti, oltre il testo. Se un testo, per mezzo di una lingua, reinventa il mondo, questo non basta: è possibile che un testo abolisca lo spazio-tempo, lo sovverta, dica l’irreale, viva l’irreale. Si tratta allora di uno strumento di verità? Non è possibile, come non è possibile tutto il contrario. Una lingua, anche manifestando l’intenzione della verità, la tradisce: è pur sempre un’emanazione del corpo, una passione. Brandelli di verità tuttavia si avvinghiano ovunque, persino nelle propagande piú stolide. Un’esperienza artistica, per mezzo di un testo, va da qualche parte. Gira, per forza, necessariamente, intorno alla morte. Perché? Perché l’esperienza artistica gira sempre intorno al corpo. Lo stesso fa la morte: gira attorno all’esperienza artistica che si compie, origlia dentro la mente di chi la compie. Non c’è niente di soprannaturale: tutto è, al massimo, invisibile.
Nei Fratelli Tanner di Robert Walser, Simon, il protagonista, cammina nel bosco innevato. Vi scopre il cadavere di un poeta, con in tasca le sue ultime poesie. Cosí morirà l’autore, Robert Walser.
È possibile non occuparsi della morte? Chi vive un’esperienza artistica non può che sentire la morte. Morire, respiro dopo respiro, in vita, come tutti. Affrettarsi piano. Stare dentro l’intervallo, il punto intermedio: abbattere cioè il punto intermedio.
L’essere umano, per sua natura, spinge verso la chiusura. Aggrotta le sopracciglia e non guarda avanti. Un’esperienza artistica è spaziosa. Essere spaziosi, sempre piú spaziosi.
Se tutto è consueto—apparentemente consueto –, l’esperienza artistica rompe questo dogma vitale: dà alla luce l’inconsueto nel consueto, nell’originario. Per questo è infinita, se non arrivasse quel fatto cosí semplice: chi scrive, chi dipinge, chi legge, chi guarda: muore.
Spaziosità: abitare poeticamente.
Stare dunque dentro ciò che non è detto che sia detto. Non è, naturalmente, una questione di forma. Alla definizione “letteraria” di distopia—“Previsione, descrizione o rappresentazione di uno stato di cose futuro, con cui, contrariamente all’utopia e perlopiú in aperta polemica con tendenze avvertite nel presente, si prefigurano situazioni, sviluppi, assetti politico-sociali e tecnologici altamente negativi”—è di gran lunga preferibile quella medica: “Lo spostamento (in genere per malformazione congenita) di un viscere o di un tessuto dalla sua normale sede”. Un’esperienza artistica è un’alterazione: una malformazione congenita. The Elephant Man è spazioso.
Essere spaziosi è vivere il dubbio. Fare il Gioco della Zona dentro se stessi. L’esperienza artistica è dentro il dubbio. Essere spaziosi è portare perennemente le sbarre dentro di sé. La spaziosità è senza nomi: “I nomi”, scrive Claude Hagège, “per sfortuna sono nomi di qualcosa”. Un’esperienza artistica non può essere uno stampo del mondo. Negli stampi del mondo, non c’è mai la polvere.
Un’esperienza artistica è un’esperienza estrema fatta di apparizioni. Luogo tranquillo della dismisura. Al centro di ogni tempesta.
Ogni parola una pietra.
Ogni istante un istante.