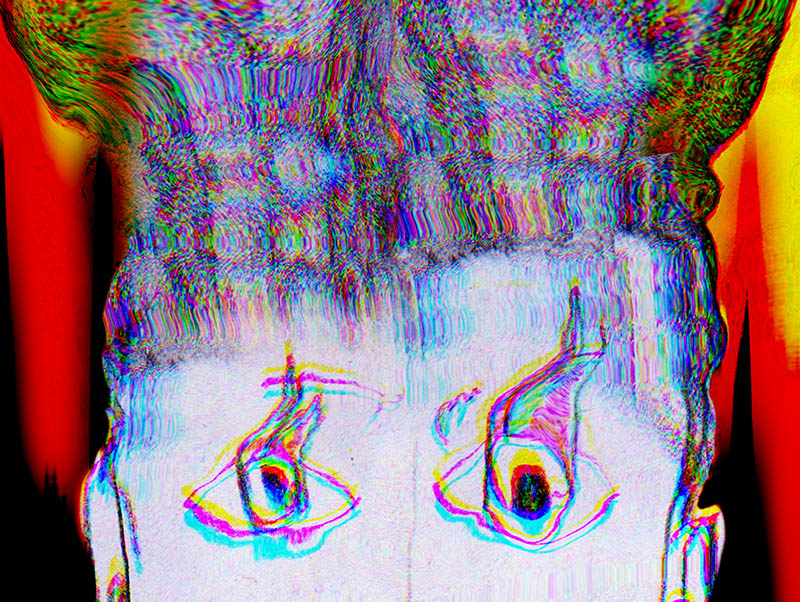La Piazza del Re
Königsplatz, la gelida mattina di fine marzo in cui la attraversai per la prima volta, era deserta e spettrale: il cielo livido, schiacciato contro le colonne monumentali del propileo e della gliptoteca, e un forte vento di tramontana alle spalle. La pioggia caduta nella notte aveva reso intollerabilmente verdi i ritagli geometrici di prato che sagomano la piazza. In passato era stata tutta ammattonata e coperta di bandiere, la chiudevano due tempietti chiamati dell’onore a memoria dei caduti del fallito putsch del 1923, che vi erano stati traslati in sedici sarcofagi di bronzo. Lì avrebbe voluto farsi tumulare anche Hitler e, se le cose fossero andate diversamente, quella mattina sarei stato in piedi di fronte al suo gigantesco mausoleo funebre.
Avevo appena visitato il Centro di Documentazione sul Nazionalsocialismo di Monaco, che sorge a pochi metri di distanza, in un edificio razionalista ed essenziale innalzato nello stesso posto dove un secolo prima si trovava il quartier generale del partito, la Casa Bruna. È qui che è iniziato tutto, aveva detto la guida, e poi aveva aggiunto E chissà, ma queste due parole erano rimaste in sospeso, come se le fossero sfuggite dalla bocca, ma ormai le aveva pronunciate e allora era stata costretta a concludere la frase, E chissà se la piazza che abbiamo davanti possa ancora dirci qualcosa, ma si fermò qui, e non disse altro, non disse niente su ciò che aveva ricominciato ad accadere ai confini orientali dell’Europa, non disse Ucraina, non disse Russia, non ce n’era bisogno, chiunque, dentro di sé, sapeva che il mondo, dalla pandemia in poi, era di nuovo uscito fuori dai cardini.
La notte delle ceneri
Oltre ad avere ospitato le prime adunate hitleriane, il 10 maggio del 1933, allo scoccare della mezzanotte, a Königsplatz, come in molte altre piazze tedesche, i nazisti avevano bruciato migliaia di libri. Bücherverbrennungen, furono chiamate queste cerimonie.
In una delle tante fotografie di quella notte si vedono centinaia di braccia sollevate nel gesto del saluto romano, intorno a un falò: militari, civili, studenti. Vi si distinguono le divise, i costumi di gala delle corporazioni. Qualcuno sorride, altri hanno le maniche delle camicie arrotolate; stringono nel pugno delle torce, come dei sacerdoti, accanto alle pire di legna e a una tribuna ornata di drappi e di bandiere. Da qualche parte, una piccola orchestra che suona. Rullano i tamburi, si indovina lo squillo delle fanfare e un odore penetrante di cellulosa e di benzina. Un odore come di vaniglia, e di muffa. La voce dei banditori annuncia il titolo di ogni opera, prima di gettarla nel fuoco; la folla acclama in coro. Chissà com’era stata la concitazione di quelle ore, tutto il movimento di libri nuovi e usati che si era riversato per le strade, le porte spalancate delle biblioteche e delle scuole, le librerie private che si svuotavano. «L’uomo tedesco del futuro non sarà più un uomo fatto di libri, ma un uomo di carattere», aveva arringato Joseph Goebbels, a Berlino, quel 10 maggio, davanti a quarantamila persone, prima di dare l’ordine di bruciare gli scritti di Heinrich Mann, di Karl Marx, di Sigmund Freud, di Albert Einstein, di Bertolt Brecht, di Stefan Zweig, di Erich Maria Remarque. «Si tratta di un atto forte e simbolico – un atto che dovrebbe informare il mondo intero sulle nostre intenzioni».
Dovetti allontanarmi di fretta verso la stazione della metro perché non avevo più consuetudine con gli spazi aperti e quell’immenso piazzale vuoto mi dava le vertigini. Ne avevo letto nei manuali di storia, ma senza ragionarci troppo: la Bücherverbrennung non era stata un’azione di propaganda occasionale, la bravata di una notte, era stato un annuncio. I roghi sarebbero continuati per tutto il 1933, e anche negli anni a seguire: si calcola che alla fine della guerra a essere bruciati siano stati centinaia di migliaia di libri, l’equivalente di una delle più grandi biblioteche al mondo, ma, come per il numero dei morti, è un conteggio approssimativo.
«Un atto forte e simbolico – un atto che dovrebbe informare il mondo intero sulle nostre intenzioni».
Che genere di burocrazia aveva prodotto questa volontà di annientamento di tutta la cultura considerata ostile al nazionalsocialismo, e anche di quella nociva e infestante che lo aveva preceduto? Quali uffici di censura e di inquisizione erano stati creati e mobilitati? Chi aveva compilato le liste di proscrizione?
Scendendo le scale della U-Bahn, un manifesto pubblicizzava le ultime uscite di una casa editrice. Ci passai davanti e mi tornò alla mente uno dei capitoli iniziali del Don Chisciotte: «Del bello e grande scrutinio che fecero il Curato e il Barbiere alla libreria del nostro ingegnoso hidalgo». Un altro pensiero mi prese alla sprovvista: nel fuoco erano state gettate anche le opere di qualche scrittore italiano?
La biblioteca di Don Chisciotte
La stanza dei libri del signore Alonso Quijiano l’ho sempre immaginata non molto grande, quasi segreta alla casa. Una sorta di cella monastica o di cappella privata, dove ritirarsi in silenzio – la lettura non è del resto una forma laica di preghiera? La illumina, alla sera, la debole luce che entra da una finestrella verticale, nell’atrio, e una candela stearica. Un tavolaccio di legno, una sedia, le pareti rivestite di scaffali. Fuori, il mulinare della polvere nelle strade bianche, e il paesaggio di una campagna agra.
È lì dentro che a furia di leggere romanzi Alonso Quijiano perse il senno e si trasformò in un uomo fatto di libri e senza carattere, l’opposto dell’i- deale proposto da Goebbels per il futuro della Germania. Un uomo talmente senza carattere da assumere comicamente l’indole e la personalità degli eroi cavallereschi di cui era così avido di conoscere le imprese. Ma se da un lato questa stanza confinava con la follia, pensai quel giorno su una metropolitana tedesca, dall’altro era prossima a Königsplatz e alle altre piazze del 10 maggio: sarebbe bastato aprire la finestra e vedere il mucchio di cenere che ancora crepitava nel cortile.
La chiave di quella stanza, il Curato l’aveva chiesta alla nipote. Era accorsa anche la serva, con una scodella d’acqua santa e l’asperges, perché il reverendo benedicesse l’ambiente e lo liberasse dal potere incantatorio dei libri, «causa di tanti malanni». L’intento non è diverso da quello di Goebbels quando parla dello spirito maligno del passato e dell’arte degenerata che hanno invaso il paese: «No alla decadenza e alla corruzione morale! Sì alla decenza e alla moralità nelle famiglie e nello stato!». Tra lui e don Pedro Pérez anche la voce sembra simile, identici i tratti: l’aria da prete, i capelli pettinati all’indietro, il volto scarno e ossuto. Soltanto l’uniforme cambia. Sarà questo restauratore dell’ordine a esaminare uno per uno i titoli dei libri presenti nella stanza e a stabilire quali meritino la pena del fuoco, insieme alla sua corte d’emergenza composta da un avvocato che di volta in volta indossa i panni del pubblico ministero o della difesa (Maestro Nicolò, il Barbiere) e da una giuria popolare (la nipote e la serva).
La biblioteca è modesta ma ben fornita: ospita, per la maggior parte, romanzi di cavalleria, romanzi pastorali, poemi epici; cento volumi assai ben rilegati, e molti altri di piccola mole. Si comincia dall’Amadigi di Gaula. Essendo il primo del suo genere stampato in Spagna, come «capo di mala setta» il Curato vorrebbe darlo alle fiamme «senza remissione alcuna». Ma il Barbiere ne invoca il perdono, proprio per via della sua originalità che lo rende il migliore tra tutti quelli che lo imitarono: il Curato accoglie l’istanza e gli preserva la vita. Per tutti gli altri il processo è istantaneo e senza appello. Colpevoli di mediocrità, di arroganza, di idiozia, oltre che dell’influenza nefasta avuta su don Alonso, dal banco degli imputati i libri sono direttamente gettati dalla finestra: il modo più veloce per trasferirli in cortile e farne una catasta da incendiare. Neppure La Galatea di Miguel de Cervantes viene risparmiata: in attesa della seconda parte, le si rifiuta per ora ogni indulgenza, perché «l’autore si intende più di sventure che di versi, propone sempre e non conclude mai».
Soltanto al nome di Bojardo, e poi a quello di Ariosto, il Curato sembra disposto a un’eccezione. «Se qui lo trovo che parli una lingua diversa dalla sua, non gli serberò alcun rispetto; ma se parla nel suo idioma, lo porterò in cima alla testa». L’italiano di Ariosto ottiene così una dispensa salvifica: l’Orlando furioso è esonerato dal rogo a patto che sia stato stampato nella sua lingua madre. Per gli altri libri che trattano le cose di Francia, si decreta invece di porli in un pozzo senz’acqua, un pozo seco, finché non sia definito il loro destino.
Mi sono chiesto spesso come sarà apparsa, quella stanza, dopo che il Curato, il Barbiere, la nipote e la serva terminarono il lavoro. Le scansie ischeletrite, la polvere sui ripiani, l’incuria, il disordine. E come sarà diventata, dopo che ne murarono la porta. Una biblioteca cieca, sommersa, violentata. La prima cosa che fa Don Chisciotte, quando si alza dal letto, dopo avere delirato per due giorni, è «di andare a vedere i suoi libri», ma non trovando più la stanza si mette a cercarla da ogni parte. Tornato nel punto in cui avrebbe dovuto essere l’entrata, si guarda intorno, smarrito, appoggia le mani sul muro. È un gesto che mi ha sempre fatto pensare a un accertamento medico, come se le avesse posate sul cuore di un animale morente, o sul proprio. Quanta disperazione dovette assalirlo quando gli dissero che era stato un mago a portarsela via?
Chissà se fu proprio la sua stanza svuotata dai libri e murata a ispirare l’artista israeliano Micha Ullman quando ideò una biblioteca composta soltanto da due materiali, il silenzio e il vuoto, per ricordare i roghi del 10 maggio 1933 nell’epicentro di tutti i punti convenuti per il fuoco, quella notte, in Germania. The Empty Library, Bebelplatz, Berlino. Una camera sotterranea di scaffali deserti in grado di ospitare gli oltre ventimila volumi che in quell’angolo della piazza furono bruciati. Una catacomba senza accesso – a che servirebbe accedervi, poi? –, ma visibile ogni giorno sotto ai piedi di ciascun passante da un oblò quadrato.
Come tre secoli prima a casa di Alonso Quijiano, anche i nazisti fecero un donoso y grande escrutinio di tutte le opere infette che avevano condotto il mondo alla follia del comunismo, del pacifismo e della psicanalisi. Ma che trattamento, stavolta, avevano ricevuto la letteratura e la lingua italiana? Erano queste le domande che non la smettevano di assillarmi, quella mattina, nella metropolitana di Monaco. Con una postilla: se il Curato è Goebbels, in questa storia, e se di servi e nipoti è inutile chiedersi il nome, tanto lunga è la lista, chi è il Barbiere?
Equinozi
Era tanto che non salivo su un aereo, che non dormivo in altri letti, che non incontravo altri esseri umani in carne e ossa. Negli ultimi due anni avevo vissuto come un eremita, barricato in un sottotetto a studiare e a scrivere tutto il giorno. La pandemia ci aveva depredato di molte cose – a me di alcuni affetti, di una certa idea di letteratura, di una certa idea di realtà – e mi aveva lasciato addosso questo senso di vuoto. Fino ad allora in Germania c’ero stato soltanto una volta, molti anni prima. Un amico aveva comprato per pochi soldi una casa d’epoca a Berlino, con delle grandi finestre bianche – un affare, aveva detto – e una primavera l’aveva affittata a me e alla mia famiglia per una settimana. Ne avevo un ricordo confuso, stanziale. Tante passeggiate, qualche museo, tre rullini di foto. Una ci ritrae ai piedi di una gigantesca statua di Marx ed Engels, e sembriamo felici.
Quest’altro viaggio era nato invece da una fortunata circostanza e dalla generosa vitalità di un’editrice di Karlsruhe, Monika Lustig. Appena le frontiere erano state riaperte, avevo ricevuto un lusinghiero invito per un ciclo di conferenze in quattro istituti italiani di cultura: Amburgo, Colonia, Stoccarda e Monaco. Non sarebbe stata una trasferta di vacanza, o almeno non esclusivamente: il programma prevedeva continui spostamenti in treno e cambi d’albergo, e non più di qualche mezza giornata libera. Un piccolo tour di mille chilometri in quattro giorni, dall’estuario del fiume Elba sul Mare del Nord giù giù verso il confine con l’Austria. Digitando l’itinerario sul telefono, era apparsa una lunga venatura blu sul dorso dell’Europa. Mancavano tre settimane a Pasqua e godevo ancora di un periodo di congedo straordinario per motivi di studio che si avviava a concludersi, non avrei dovuto neppure chiedere giorni di ferie all’amministrazione della biblioteca dove lavoro. Così mi era bastato organizzarmi, accettare la proposta e salire su un volo della Lufthansa il sabato di fine marzo in cui cambia l’ora, una delle due sole date dell’anno nelle quali la notte è uguale al giorno. Partire, in fondo, è assai più semplice che decidere di farlo, e cambiare aria mi avrebbe fatto bene.
Le pareti dell’aeroporto di Amburgo, mentre ci si avvia verso l’uscita, sono un gigantesco murale affollato di scritte a caratteri cubitali. Testimonianze, ricordi, impressioni di gente famosa. In una di queste, John Lennon confessa di essere diventato uomo in questa città. Era stato in un club amburghese, dove i Beatles avevano esordito, una sera di metà agosto del 1960. Non avevano vent’anni e abitavano nel retro di un cinema dismesso, nel quartiere a luci rosse di St. Pauli. Non dovevo incontrare nessuno fino all’indomani, così mi ripromisi di andarci subito: mi hanno sempre interessato gli esordi degli artisti, i segreti che contengono e non sono mai indagati abbastanza.
All’aeroporto salii su un treno che mi portò alla stazione ferroviaria centrale: da lì avrei potuto raggiungere l’hotel a piedi e liberarmi dei bagagli. Ma sul binario di fronte centinaia di donne e di bambini in fuga dal confine orientale ucraino stavano scendendo da un altro convoglio e riempiendo la banchina di bandiere. Una cosa del genere l’avevo letta soltanto sui libri di storia, e presto ebbi pudore anche di guardare. Il mondo era ricaduto «in un buio così nero e profondo» che «pareva di essere entrato col capo in un calamaio pieno di inchiostro», aveva scritto Collodi centoquaranta anni prima. Non so se fosse stata di nuovo una balena o un pesce-cane a ingoiarci o noi a colare a picco, ma certo anche la nostra storia era tornata a essere la storia di un naufragio, e di un naufragio collettivo. Eppure dal ventre di quell’animale, al chiarore di un’altra candela stearica come quella con cui si faceva luce Mastro Geppetto o il signore Alonso Quijiano nella sua stanza dei libri, mi era parso finalmente di vedere come stavano realmente le cose. Ero approdato ad Amburgo con un piccolo taccuino in tasca e una domanda martellante nella testa: non potendo più usare quello di prima, con quale inchiostro, ora, avrei dovuto scrivere? E leggere? E ricordare?
Alcuni bruciavano i libri da soli
In pochi giorni, trascrissi sul mio taccuino l’elenco di tutti i roghi di libri di cui è rimasta, nella «storia umana», almeno una diceria. Niente era stato risparmiato, e da nessuno: l’Escorial, Bagdad, Alessandria, le tavolette sumere e i libri della commedia di Aristotele, i papiri di Ercolano, la Torah, il Talmud, la Bibbia, il Corano, i testi contrari alla dottrina cattolica ma anche a quella islamica, Pietro Abelardo e Arnaldo da Brescia, il volgare e l’arabo, l’ebraico, il latino, i poemi classici e i trattati di filosofia, i libri erotici e i manoscritti maya, Voltaire, Diderot e Rousseau, La capanna dello zio Tom e il J’accuse di Émile Zola. Califfi, vescovi d’Italia e del Messico, frati predicatori, imperatori cinesi, romani e francesi, concili e tribunali ecclesiastici si erano accaniti contro tutto ciò che ritenevano avverso, immorale o blasfemo. La letteratura, riassunse Antonio Tabucchi, ha gli stessi nemici di sempre, gli stessi detrattori, avversari, interni ed esterni, e gli stessi sicari.
L’eco anche simbolica di una devastazione tanto estesa e la sua feroce ripresa nella Germania nazista è tale da spingere qualche anno dopo la fine della Seconda guerra mondiale un giovane scrittore di fantascienza, Ray Bradbury, a rappresentare un mondo alla rovescia nel quale i pompieri, la «milizia del fuoco», hanno il compito di incendiare le abitazioni di tutti quelli che conservano dei libri. Tutto nasce da un breve racconto, The Fireman, che poi Bradbury sviluppa e chiama Fahrenheit 451, i gradi di temperatura a cui la carta brucia.
Ma se la lista dei roghi di libri è infinitamente lunga, ancora più difficile è tenere il conto o compilare un registro di tutti i libri censurati e mandati al macero. Negli ultimi quattro secoli, il Curato, il Barbiere, la nipote e la serva di Don Chisciotte avrebbero avuto un gran da fare a discutere del destino di tanti titoli potenzialmente scandalosi e sarebbero stati costretti ad accrescere considerevolmente la catasta in cortile. E forse non avrebbero mai immaginato che lo stesso romanzo che li contiene sarebbe stato il primo a essere proibito dal generale Pinochet, all’indomani del colpo di Stato dell’11 settembre 1973, perché giudicato il capostipite di tutta la letteratura sovversiva, insana e pericolosa del nostro tempo, e per di più in lingua spagnola.
La macchina dell’oblio, tuttavia, ha molte soluzioni. Per alcuni gruppi etnici, autori come il leader politico curdo Abdullah Öcalan, teorizzatore di una tra le più avanzate teorie politiche contem- poranee, il confederalismo democratico, non compaiono nelle liste nere della Turchia, che regolano anche la circolazione dei libri nelle carceri, per non riconoscerne neppure l’esistenza. È una sorta di condanna ancora più radicale: li si tratta alla stregua di fantasmi, sono cancellati dagli elenchi dei divieti perché si vuole raschiare il loro nome dalla storia e da qualsiasi documento. Come se non avessero mai scritto un rigo, come se non fossero mai nati. Per metterli in salvo, i loro libri vengono sotterrati dalla popolazione nelle montagne. O si è costretti a bruciarli, perché esserne trovati in possesso può costare la vita.
«Tutti i miei amici hanno dovuto distruggere la loro intera biblioteca almeno una volta», ricorda Bachtyar Ali, uno scrittore curdo che mi aveva consigliato il compagno di mia figlia. «Alcuni bruciavano i libri da soli, oppure lo facevano i parenti per evitare problemi. Chi non riusciva a farlo, scavava fosse profonde in cui seppellire i libri . . . La mia infanzia è stata caratterizzata dal pericolo dei libri. Ancora oggi li associo a sentimenti di colpa e trasgressione». La lettura, in Oriente, conclude Ali, è un’attività molto rischiosa. Da quelle parti, i libri non sono innocui nemmeno nelle biblioteche pubbliche perché la polizia segreta controlla anche le liste dei prestiti. «Gli stati dell’Oriente, compreso l’Iran, non temono i libri in sé, ma i lettori. Un vero lettore con molti libri è sempre sospetto . . . I lettori sono più pericolosi dei libri. Un lettore, anche se non legge i libri proibiti, è una potenziale minaccia per chi detiene il potere in Oriente».
Quando Bachtyar Ali fuggì in Germania, durante il primo interrogatorio come rifugiato, alla domanda dell’ufficiale di polizia sui motivi della sua richiesta di asilo rispose che, anche se le ragioni erano molte, era venuto soprattutto per poter leggere finalmente in pace. «Non ho mai sentito niente del genere – rispose l’ufficiale. – Qui non diamo asilo a nessuno perché possa leggere». Bachtyar Ali sorrise. «No, stavo solo scherzando». Quello sguardo gli aveva fatto capire che i lettori non sono popolari in tutto il mondo.